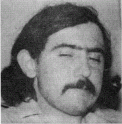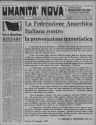A colloquio con lo studioso Vincenzo Mantovani, che da tre anni si sta occupando della ricostruzione storica dell’attentato commesso a Milano nel 1921 al teatro Diana – Lo sciopero della fame di Malatesta alla base del tragico gesto di protesta – La complessa realtà del ristretto nucleo di terroristi anarchici allora operanti a Milano – Nelle nobili parole di Malatesta la netta condanna dell’attentato ma non dei suoi autori
Nel corso della trasmissione televisiva dedicata all’anarchia, andata in onda mercoledì I ottobre, ampio spazio è stato dedicato alla tragica vicenda dell’attentato al Teatro Diana. E, puntualmente, la versione che ne è stata fornita non ha sortito altro effetto che quello di rispolverare la tradizionale oleografia dell’anarchico bombarolo e terrorista.
Indubbiamente l’intera vicenda dell’attentato al Diana non è ancora stata chiarita, e probabilmente non lo potrà mai essere in ogni suo aspetto. Ciò nonostante è necessario cercare di comprendere la realtà sociale dell’epoca e di acquisire quanti più dati di fatto possibile per far luce su quella tragica vicenda. Tanto più che ancora ai giorni nostri – cioè oltre mezzo secolo dopo – l’attentato al Diana viene “scagliato” contro gli anarchici ogni qual volta il Potere vuole riprendere la persecuzione e la campagna di diffamazione contro l’anarchismo.
A parte un volume autobiografico steso da uno dei tre anarchici autori dell’attentato (G. Mariani, Memorie di un ex-terrorista, Torino 1953), poco o niente è stato finora scritto in campo anarchico per approfondire la vicenda del Diana. Non sarà quindi inutile riprendere un attimo seriamente il discorso: ecco la ragione dell’articolo che segue, frutto di una lunga conversazione con un giovane studioso, Vincenzo Mantovani. Partito tre anni fa con l’intenzione di scrivere un libro sull’attentato al Diana, mantovani ha lavorato in tutto questo periodo ad una attenta ricostruzione non solo del fatto in sé, ma anche – e soprattutto – dell’ambiente sociale e politico nel quale l’attentato si produsse. La sua ricerca ha quindi progressivamente allargato il suo ambito giungendo ad abbracciare la storia del movimento anarchico a Milano dalla fine della guerra fino al processo per l’attentato, cioè dalla fine dei 1918 alla primavera del ’22. Il lavoro di ricerca e di ricostruzione storica che sottende il suo libro – che probabilmente si intitolerà “Mazurka Blu” (dal titolo dello spettacolo in programma al Teatro Diana quella sera) – il suo lavoro, dicevamo, non è ancora finito: ma è a buon punto, tale da rendere possibile un attento riesame dell’intera vicenda.
Terminiamo queste necessarie note di presentazione con l’avvertenza che Mantovani, pur essendo ideologicamente vicino alle posizioni P.D.U.P., nutre simpatia nei confronti dell’anarchismo – almeno in sede storiografica.
“Se gli anarchici non se ne curano, la storia la faranno i loro nemici“: così, con questa semplice e pur così vera constatazione, Gaetano Salvemini riuscì a convincere l’anarchico Armando Borghi a scrivere le memorie della sua vita. Un concetto non dissimile esprimeva Vittorio Emiliani quando, nella prefazione alla antologia di scritti di Borghi Vivere da anarchici (da lui curata), affermava che “agli anarchici è toccata una curiosa sfortuna storica, almeno in Italia: o sono stati dipinti a tinte romanzesche, come personaggi avventurosi, pittoreschi e niente più, oppure sono stati passati al vaglio di una storiografia comunista tesa ad accumulare i documenti quasi per un processo dell’anarchismo più che per una critica serena e obiettiva. Né, talvolta, sorte migliore è toccata agli anarchici italiani quando ad occuparsi di loro sono stati storici di formazione riformista“.
Il mio interlocutore insiste più volte su questo concetto rammaricandosi che anche sull’attentato al Diana poco, troppo poco sia stato scritto da parte degli anarchici. Ne convengo subito anch’io, convinto come sono che spesso tacere altro non significa che lasciare campo aperto alle falsità ed alle speculazioni dei nostri nemici. Dunque, la “verità” sul Diana: ecco l’oggetto di questo colloquio con Vincenzo Mantovani.
Le linee essenziali del fatto sono note. Per protestare contro la prolungata detenzione di Errico Malatesta, Armando Borghi e Corrado Quaglino (in carcere da cinque mesi senza ancora essere stati rinviati a giudizio) tre anarchici – Giuseppe Mariani, Giuseppe Boldrini ed Ettore Aguggini – fecero esplodere ben 160 candelotti di dinamite all’esterno del teatro-albergo Diana, la sera del 23 marzo 1921, causando una tragica strage fra il pubblico e gli orchestrali del teatro. Bilancio finale: 21 morti e un’ottantina di feriti. Perché l’attentato fu commesso proprio al teatro Diana?
A questa domanda la trasmissione televisiva “Una parola, un fatto” dedicata all’anarchia non ha voluto rispondere, anzi diciamo pure che non se l’è nemmeno posta. Il che – prosegue Mantovani – è molto grave, perché così facendo si è accreditata la “solita” storia dello anarchico che, spalancata la porta di un teatro, dissemina la morte ed il terrore, coscientemente e volontariamente. Quella sera il carico di esplosivo fu depositato al di fuori del teatro, con l’intenzione di colpire non il teatro quanto il soprastante albergo – che, secondo informazioni allora in possesso degli attentatori, serviva regolarmente da luogo di incontro tra Benito Mussolini ed il questore di Milano Gasti, entrambi acerrimi nemici degli anarchici e da questi ultimi odiati, in particolare, si credeva che proprio quella sera Gasti si dovesse trovare in quell’albergo.
La decisione di attentare al teatro-albergo Diana, comunque, era stata presa all’ultimo momento, poiché – spinti dall’esigenza di “far qualcosa” per appoggiare lo sciopero della fame attuato dall’anziano Malatesta e dagli altri due (Borghi, Quaglino) per ottenere la fissazione del processo – la prima intenzione era stata quella di far saltare in aria la Questura centrale di piazza San Fedele. Nel volume autobiografico del Mariani si parla apertamente di questo primo proposito, che non potè essere attuato per sopravvenute difficoltà d’esecuzione.
Inevitabilmente, il discorso cade sul più generale problema del “terrorismo”, o meglio della pratica terrorista quale fu attuata da un ristretto numero di anarchici (una decina, al massimo) a Milano tra la fine della guerra e l’attentato al Diana. Questo attentato – precisa Mantovani – fu infatti l’ultimo di una serie, anche se certamente il più tragico e clamoroso. Il primo attentato, nel periodo da noi considerato, era stato quello effettuato dal giovane Bruno Filippi al palazzo di Giustizia di Milano, il 29 luglio 1919, per ricordare Gaetano Bresci nel diciannovesimo anniversario del suo riuscito attentato contro il “re buono” Umberto I. In quell’occasione una modestissima bombetta aveva abbattuto un muro, provocando scompiglio tra i magistrati ma nessuna vittima. Due mesi più tardi era sempre il giovane Filippi che, insieme con gli altri due componenti del suo gruppetto terroristico (Guido Villa, Aldo Perego), effettuava un attentato in Galleria contro il caffè Biffi, noto ritrovo dei “pescecani”, cioè dei borghesi arricchitisi coi profitti di guerra. Questo attentato provocava una vittima: il povero Filippi, infatti, saltava in aria con la sua bomba dimostrativa e moriva. Con l’arresto degli altri due suoi compagni e la morte di Filippi, quel primo gruppetto di anarchici terroristi cessava forzatamente la sua attività.
Mantovani ci tiene ad approfondire l’analisi di questi fatti e dei loro autori, poiché e gli uni e gli altri costituiranno poi l’humus dell’attentato al Diana. Indubbiamente quei giovani si rifacevano agli individualisti francesi di fine ‘800 per quanto riguarda l’uso di materiale esplosivo come mezzo di lotta sociale: ma va soprattutto sottolineata la loro netta sensazione di non essere che degli “avamposti” della più generale lotta sociale. In prima fila nei grandi cortei proletari e negli scontri coi tutori dell’ordine, essi stessi d’origine e di collocazione sociale proletaria, Filippi ed i suoi emuli davano tutto se stessi per la causa della rivoluzione sociale. Non disprezzavano la lotta di massa, anzi ritenevano che i loro atti terroristici avrebbero potuto ricondurre sulla via dell’azione diretta quei larghi settori della classe lavoratrice che soggiacevano all’influenza, per loro estremamente negativa, del socialismo riformista. Mai dunque atti individuali fine a se stessi – ribadisce il mio interlocutore – ma sempre collegati, almeno nelle intenzioni, con la più generale lotta rivoluzionaria del proletariato. Mantovani cita come esempio il primo attentato di Filippi, quello contro il palazzo di Giustizia, e sottolinea il valore che nelle intenzioni del suo autore questo gesto doveva avere: dimostrare cioè che la Magistratura con la “M” maiuscola, quella tanto riverita e temuta da tutti, non era poi così inattaccabile, dal momento che qualcuno poteva facilmente seminare il panico nel tempio della giustizia di Stato con una semplice, quasi innocua bombetta. Attentati ben discriminati, dunque, questi degli anarchici milanesi in quel periodo: ben discriminati e “firmati”. Certo – sottolinea Mantovani – gli anarchici hanno sempre firmato i loro attentati: non si poteva pretendere che per firmarli lasciassero sul posto il loro nome o comunque elementi tali da portarli al più presto in galera – sarebbe assurdo il pretenderlo. Ma, comunque, una volta arrestati, quei giovani terroristi non rinnegarono mai le proprie responsabilità, anzi le rivendicarono come atti di lotta contro l’ingiusto sistema sociale. Così appunto fecero Villa e Perego al processo per la bomba al Biffi, così faranno poi Mariani, Boldrini e Aguggini al processo per la strage del Diana.
Per comprendere il clima nel quale si produssero alcuni “botti” di scarso rilievo e quindi quello tragico del Diana è indispensabile fare riferimento alla situazione del vecchio Malatesta, arrestato con altri suoi compagni il 17 ottobre del ’20 in un momento in cui, sconfitto il moto dell’occupazione delle fabbriche, la borghesia riprendeva saldamente in mano le redini del potere, fiancheggiata dal montante fascismo squadrista. L’arresto e la prolungata detenzione di Malatesta costituivano una chiara provocazione nei confronti della sinistra: eppure nessuno – a parte il capitano Giuseppe Giulietti, segretario della federazione dei lavoratori del mare e amico personale di Malatesta (era stato lui a renderne possibile il rimpatrio clandestino nel dicembre del ’19) – nessuno si era mosso in favore del vecchio anarchico e dei suoi compagni. Questo silenzio dei socialisti ed in genere del movimento operaio provocava tra gli anarchici una profonda insofferenza, quasi la sensazione di essere stati lasciati soli proprio in una circostanza particolarmente dura. Confrontando poi questo atteggiamento delle altre forze di sinistra con le entusiastiche accoglienze riservate a Malatesta all’indomani del suo rientro in Italia da parte di tutto il proletariato, gli anarchici “sentivano” che fosche nubi si addensavano all’orizzonte. Si aggiungano le sempre più criminali imprese delle squadracce nere, l’ormai lampante connivenza delle autorità con le bande di Mussolini e camerati, il forzato allontanarsi della vittoria rivoluzionaria: il quadro non era certo allegro.
Quando poi uscì dalle carceri di San Vittore la notizia che il quasi settantenne Malatesta aveva iniziato (il 18 marzo) uno sciopero della fame a tempo indeterminato, per ottenere la sola fissazione del processo, la tensione tra gli anarchici riprese a salire. Il “caso Malatesta” era di nuovo sui giornali, dopo mesi di complice silenzio; Umanità Nova usciva in quei giorni con titoloni a tutta pagina invitando alla mobilitazione in sostegno degli scioperanti, rimproverando quanti continuavano a non far niente per Malatesta dopo averlo tanto acclamato in passato. Il 23 marzo – quinto giorno dello sciopero della fame dei reclusi – mentre ormai tra gli anarchici si cominciava parlare della possibile morte del vecchio Malatesta, si diffuse la notizia che probabilmente in giornata il giudice istruttore avrebbe concesso la libertà provvisoria ai tre anarchici.
A questo punto conviene ritornare al gruppetto terroristico composto da Aguggini, Boldrini e Mariani – questi ultimi due chiamati a Milano da Mantova dal primo, per “fare qualcosa” insieme in favore di Malatesta. Datisi appuntamento in un prato di periferia per la sera del 23, vennero informati che nessun fondamento avevano le voci circolanti in città relative alla concessione della libertà provvisoria ai tre anarchici detenuti a San Vittore: il giudice istruttore, infatti non aveva concesso ciò che essi avevano sperato. Nell’ascoltare quella brutta notizia, i tre si decisero che era davvero giunta l’ora. Malatesta era sul punto di morire: non c’era più tempo da perdere. Certo in quei momenti ben vivo doveva essere alle loro menti il ricordo della tragica vicenda del sindaco della cittadina irlandese di Cork, il quale non molti mesi prima si era lasciato morire di fame in carcere (anche Umanità Nova aveva a suo tempo seguito quella vicenda): in ogni modo, a ogni costo, Malatesta doveva vivere – questo il loro pensiero, questo il pensiero di tutti gli anarchici.
Raggiunto il teatro Diana, vi depositarono all’esterno il carico micidiale e si allontanarono. Ciò che avvenne in quei momenti non ha mai potuto essere ricostruito con sicurezza; secondo una versione, un legionario fiumano avrebbe spostato la dinamite all’ultimo momento prima dell’esplosione. Ma niente – lo ripetiamo – è stato provato, né mai lo potrà essere. Con tutta probabilità. Sta di fatto che l’orrenda esplosione ebbe luogo, con le luttuose conseguenze cui già abbiamo accennato.
Nel breve volgere di poco tempo bande armate fasciste distrussero sia la sede di Umanità Nova sia quella dell’U.S.I., tentando poi l’assalto alla nuova sede dell’Avanti! Subito dopo ebbe inizio la sistematica “caccia all’anarchico” da parte della polizia: decine ne furono fermati, minacciati, incarcerati, finché si arrivò all’individuazione del terzetto responsabile della strage. Diciassette altri anarchici, assolutamente estranei al fatto, furono accomunati dalla polizia a Mariani, Boldrini ed Aguggini: tutti insieme furono processati nella primavera del ’22, in quella stessa Milano ormai sempre più in balia dello squadrismo nerocamiciato.
Oltre alle tre condanne all’ergastolo per i tre autori della strage, decine di anni di galera vennero inflitti agli innocenti cinicamente travolti dalle manovre congiunte della polizia e della magistratura.
Errico Malatesta, nel frattempo (luglio ’21), era stato assolto da tutte le accuse mossegli dalla polizia: la magistratura aveva dovuto liberarlo confermando così clamorosamente l’ingiustizia della sua lunga detenzione. Anche di ciò bisogna tener conto – sottolinea Mantovani – nel valutare la vicenda del Diana. La liberazione di Malatesta assumeva infatti il valore di una conferma delle ragioni che avevano spinto i tre terroristi al loro tragico gesto di protesta e di solidarietà.
P. F.
***
L’opinione di Malatesta
Assolto nel luglio del ’21 da tutte le accuse mossegli, Errico Malatesta riprendeva il suo posto alla direzione del quotidiano anarchico “Umanità Nova”. Quando, nel maggio dell’anno successivo, si teneva a Milano il processo contro gli attentatori al Diana (e contro altri diciassette anarchici assolutamente estranei al tragico fatto), Malatesta pubblicava un articolo dal significativo titolo “Tormento d’animo”. Ne riproduciamo ampi stralci.
Mentre a Milano si svolgono dolorose le tristi scene del processo, una tempesta spirituale agita gli animi dei compagni.
Quegli uomini (parlo dei confessi, chè gli altri sono vittime delle malvagie ambizioni poliziesche dei Gasti e dei Rizzo) quegli uomini uccisero e straziarono nella carne umana, carne d’inconsci e d’innocenti, senza criterio di giustizia e senza utilità per alcuno.
Forse essi non si rendevano conto della forza terribile della loro macchina infernale e quello che voleva essere una protesta incruenta fu invece una strage immane; ma i morti, i mutilati son là, e l’orrore della cosa agghiaccia il cuore, offende il senso profondo di umanità che sta in ogni uomo normale e non lascia tempo o serenità per un esame rigoroso ed un calcolo esatto delle responsabilità. Comprendo: comprendo che ciò sia per un tempo, ma non comprendo che il dolore e l’orrore abbiano ad offuscare permanentemente la ragione, o altrimenti fra gli orrori simili e peggiori che avvengono tutti i giorni, le sorti della civiltà, le sorti dell’umanità sarebbero compromesse e perdute per sempre.
Gli anarchici che sanno comprendere le influenze determinanti dell’ambiente tante volte in contrasto con le spinte intime della volontà, gli anarchici che intendono le necessità crudeli dei conflitti sociali in una società retta dalla violenza e sono disposti a lottare senza debolezza fino al trionfo della libertà e della giustizia per tutti, ma lo fanno senza odio e pronti sempre a perdonare e dimenticare, gli anarchici soffrono come gli altri e più degli altri di ogni violenza eccessiva, di ogni dolore inflitto senza necessità – e nel caso dell’eccidio del “Diana” non avrebbero che da dolersi come di qualsiasi altro grande delitto o altra grande disgrazia.
Ma quegli uomini, i bombardieri del “Diana”, erano compagni nostri, buoni compagni nostri, pronti sempre al sacrificio per il bene degli altri, e nel compiere il loro tragico ed infausto gesto intendevano fare opera di sacrificio e di devozione. Quegli uomini hanno ucciso e straziato degli incolpevoli in nome della nostra idea, in nome del nostro e del loro sogno d’amore.
E qui sta la tragedia che tormenta tanti nostri compagni.
Rivendicare il fatto, tanto contrario ai nostri sentimenti ed agli interessi della nostra propaganda, è assurdo, impossibile.
Condannare gli autori è ingeneroso, ingiusto, impossibile.
Bisogna comprendere (…)
I dinamitardi del “Diana” furono travolti da una nobile passione, ed ogni uomo dovrebbe arrestarsi innanzi a loro pensando alle devastazioni che una passione, anche sublime, può produrre nel cervello umano (…)